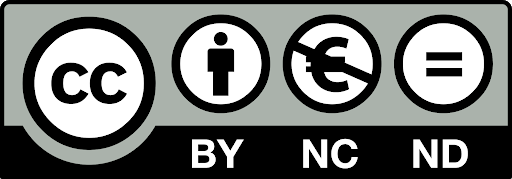L’acqua, usata per svariati motivi soprattutto per dissetarsi, per l’igiene personale ma più di ogni altra cosa per lavare i panni. Ed in alcuni borghi del Cilento, ancora oggi sono visibili alcune strutture, realizzate di solito dalle amministrazioni pubbliche dell’epoca, diversi risalgono ai primi del ‘900, i cosiddetti “lavaturi” – lavatoi, utilizzati dalle donne del luogo per il lavaggio della biancheria. Fino agli anni sessanta del XX secolo, i panni venivano lavati a mano nei “lavaturi”, o al fiume; essi divenivano punti d’incontro e di socializzazione, erano posti dove si sparlava e si mettevano in piazza i fatti di tutti, era qui che si raccontavano i fatti e i misfatti del giorno e si orchestravano i più piccanti pettegolezzi sulle persone più in vista del paese, allo stesso tempo si creavano amicizie molto strette e ci si aiutava in caso di bisogno. Difatti alcuni dei luoghi più importanti del paese erano le fontane o i lavatoi.
Di solito il lavatoio era situato fuori del paese, qualcuno, pochi a dire il vero, dentro i grandi portoni dei palazzi dove abitavano cinque o sei famiglie. I “lavaturi”, provvisti di fontane avevano la cannella con l’acqua sempre corrente ed erano fornite di due vasche: in una si lavavano i panni e nell’altra si risciacquavano.
Di solito i panni in una famiglia, era l’epoca in cui si viveva in nuclei familiari allargati e si arrivava facilmente a 10 persone e il cumulo della biancheria riempiva decine di ceste, venivano lavati dalla madre e dalle figlie, poche erano le lavandaie di professione, povere persone che giravano per le case delle famiglie benestanti e che si accontentavano di venir pagate con formaggio, pane, olio o pochi soldi. Complicata e dispendiosa in tempo questa operazione, i panni, dopo essere stati lavati e portati a casa, venivano imbiancati con la cenere.
I “lavaturi” erano di due tipologie: uno più strutturato, con tettoia di copertura e larghe e lunghe lastre di pietra all’interno di un fossato costruito a fianco dell’acqua corrente, che consentiva un utilizzo in piedi più comodo ed ergonomico; l’altro, più semplice, dotato di una pietra più piccola sulla quale sbattere i panni, appoggiata direttamente sulla riva del ruscello da utilizzarsi in ginocchio, sulla nuda terra, molto più scomodo e stancante. Anni fa, ogni settimana o mese si svolgeva il rito del bucato più piccolo mentre in primavera quello voluminoso (come lenzuola o asciugamani), perché era il periodo migliore per l’abbondanza di acqua data dal disgelo.
Quasi con ferocia, le lavandaie sbattevano a forza i panni sulla pietra, operazione importante per eliminare qualsiasi residuo che poteva danneggiare il tessuto o lasciare aloni. Prima di metterlo ad asciugare, il bucato andava strizzato ben bene: i capi tenuti fra due donne, facendoli girare in parti opposte, poi veniva disteso sui prati per l’asciugatura o sui cespugli per evitare che animali potessero calpestarli. I detersivi del tempo, oltre a cenere e sapone, erano: varichina, soda, borace, calce, caolino e il preziosissimo aceto. Per inamidare i capi, invece, si facevano bollire delle bucce di patate e, in quest’acqua, vi si immergevano i panni.
Il risultato finale era perfetto e non costava nulla, e se capitava di lavare a casa i panni, l’acqua rimasta nel mastello la si utilizzava per lavare i panni colorati e, addirittura, per lavarsi i capelli che acquistavano in brillantezza. Nulla era buttato, tutto veniva recuperato e l’inquinamento era una parola ancora sconosciuta. Grazie ad alcune Amministrazioni Locali, molte di queste opere sono state riportate agli antichi splendori, anche se a molti potrebbe apparire un lavoro inutile, ma è importante anche rivalutare queste piccole e preziose testimonianze di un passato che ci appartiene. I “lavaturi” vere e proprie installazioni artistiche , elementi che danno forma all’acqua, caratteristici nella vita di questo territorio. L’acqua è “sorgente di vita ma anche elemento da sempre indissolubilmente legato al destino del Cilento, elemento imprescindibile anche per la formazione delle strutture architettoniche montane di questo spicchio d’ Italia.