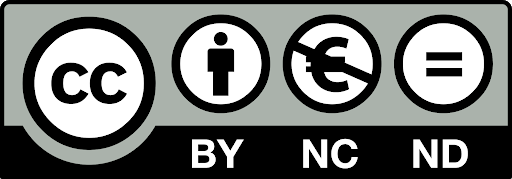“Mmòsse”: sostantivo plurale femminile del dialetto cilentano, qui volutamente riportato con una doppia “M” per evidenziare la pronuncia marcata della consonante iniziale con cui il termine viene adoperato nell’uso parlato.
Nel dialetto cilentano il termine assume un significato diverso rispetto allo stesso vocabolo riportato nei dizionari di lingua italiana.
Il termine è usato per lo più al plurale, spesso preceduto dal verbo “fare” in espressioni dirette del tipo: “Ma nun fà mmòsse!”, o anche da solo in espressioni indirette come “E quànda mmòsse ca fàce ppè nu poco re raffreddòre!”.
“Mmòsse”, ad una spiegazioni superficiale, parrebbero mere esternazioni di atteggiamenti, lamenti, moine. In realtà nascondono un codice di significato più profondo. Nel dialetto cilentano il far “mmòsse” racchiude una serie di condotte riconducibili ad un’ampia gamma di “simulazioni” manifestate sia con una mimica del corpo (quando, ad esempio, si vuol simulare come acuto un dolore fisico probabilmente leggero o inesistente), sia con dichiarazioni dirette a descrivere una situazione caricandola di tragico inverosimile (come, ad esempio, quando molti dichiaravano nel periodo sel c.d. “lockdown”, di non poter mangiare ma che all’estate successiva postavano foto in alberghi di lusso), oppure abbinando i due modi di manifestazione.
Far mmòsse, quindi, significa “simulare”, “fingere”, “esagerare”, “lamentare e lamentarsi oltre modo e in modo scenico e plateale”; possono essere ingenue (come nei bambini), ma anche meditate, sempre con un obiettivo diretto a riceverne una utilità, quand’anche sotto forma di compassione fine a sé stessa, ma più spesso con l’intento di riceverne un beneficio di ordine materiale o per sottrarsi ad un dovere o ad un impegno.
La casistica del quotidiano enuclea una particolare manifestazione di “mmòsse” in occasione di piccolissimi e insignificanti incidenti stradali, quelli da semplice strisciata per intenderci, in seguito ai quali il conducente danneggiato inscena un’agonia già con l’obiettivo di lucrare sul risarcimento dell’assicurazione. Una volta vidi un signore che, appena dopo il lievissimo incidente, se ne stette sdraiato sulla strada in attesa dell’ambulanza, ma approfittando di quel tempo per fumare beatamente una sigaretta con tanto di espettorazione di fumo.
Anche nella versione al singolare “a mmòssa” assume un significato particolare, sempre legato al simulare o sceneggiare. In espressioni del tipo “é vero ca chìro ca nun t’a cercato soldi, ma putìvi fà sibbènga ‘a mmòssa r’u pavà”. Far la “mmòssa”, usato al singolare, significa quindi porre in essere un’azione simulata, magari solo accennata o vagamente promessa, ma senza alcuna reale intenzione di porla in essere, così, per mera cortesia o per protocollo rituale.
Antropologicamente, le “mmòsse” sono la manifestazione di un’indole, tutta italiana e meridionale in particolare, incline al teatro, alla scena, all’espediente, quale si può riscontrare non solo negli strati più umili della popolazione, ma anche tra persone di rango culturale presumibilmente elevato (e ho visto colleghi avvocati, abilissimi a “far mmòsse” davanti a un giudice per perorare un provvedimento favorevole al loro cliente).
Probabilmente nel significato profondo del far “mmòsse” si nasconde il significato del proverbio meridionale “chi chiànge fòtte a chi rìre”).