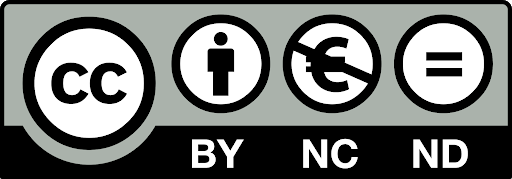“Ciùngo”, aggettivo maschile singolare del dialetto cilentano, e meridionale in genere. Al femminile si dice “ciònga”, mentre la forma verbale contratta all’infinito presente è “ciungà'”; declinato al presente indicativo suona: ciòngo, ciunghi, ciònga, ciungàmo, ciungàti, ciòngano.
“Ciùngo” è tradicibile con “immobile”, “paralizzato”. Per maggior precisione esprime tutte le diverse gradazioni di malessere derivate sia da prolungata inattività, sia da sforzo, e che in ogni caso si ripercuotano sulle articolazioni del corpo umano. Pertanto, si può essere “ciùngo” per aver zappato l’orto come dice chi si senta dolori alla schiena e alle braccia per la postura e le sollecitazioni alle braccia (“m’aggio ciungàto a zappà’ l’uòrto”).
In questi casi indica una condizione passeggera rimediabile con il riposo. Può definirsi “ciùngo” chi sia costretto a periodo prolungato di inattività tale da indebolire le articolazioni (“a sta’ chiuso a la casa, m’aggio ciongàto ca nu me firàva chiù”).
Nella versione severa indica una grave condizione di invalidità che compromette la deambulazione fino all’allettamento.
Nella vita quotidiana si adopera la forma verbale “ciungàre” nelle espressioni di biasimo o di rimprovero: se ad esempio il bambino prova ad allungare le mani per afferrare clandestinamente un dolce sulla tavola, potrà essere redarguito con l’espressione “pròva n’ata vota ca te ciòngo le mmàno!”.
Negli anatemi (o “iastème”) è difficile che sia usata come vero augurio di malasorte, ragion per cui le espressioni del tipo “puòzzi ciungà!” devono leggersi, per lo più, in contesti amicali sia pur a volte animati Infatti, il cilentano teme, per mentalità, la “iastèma” di ritorno, ossia la cattiva sorte malaugurata agli altri, ma che si ritorce contro sé stessi (e nelle realtà povere ricorreva la visione dello storpio dalla nascita destinato ad una vita talmente infelice che induceva a guardarsi bene dall’augurare per davvero una simile sorte anche al nemico peggiore).
Non vi è una etimologia acclarata sul vocabolo. L’etimo del verbo “ciungàre”, come dell’aggettivo “ciùngo”, potrebbe derivare dal latino “ex-iungere”, inteso come contrario del verbo “iùngere” che sta per “congiungere”, “unire”, e che si riconosce nell’altro verbo dialettale “iònge” che, di contro, significa appunto “legare”, ma con la finalità di ricreare, riparare, o ripristinare una funzione o una utilità collegando due oggetti disuniti o separati.
Questa ipotetica etimologia pare in linea con il fenomeno della “disarticolazione” anatomica, caratterizzata dalla disfunzione che si crea nei punti di unione delle ossa. Il “ciungàre”, quindi, sarebbe una disgiuntura di ossa (come le vertebre, ad esempio) che non si legano più alla perfezione provocando difficoltà di movimenti.
Secondo alcuni, invece (Francesco Marciano, in “A Grazia Vosta”, 2007), la “etimologia di ciunco deriva dal latino volgare truncare = mozzare, danneggiare. Anche nell’italiano antico “ciunco” sta per troncato, mozzato, e chi ha un arto mozzato non lo può adoperare perché paralizzato”.