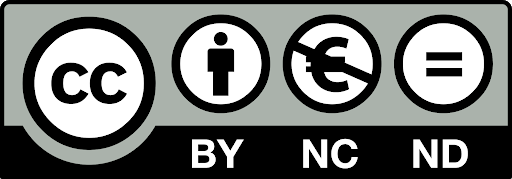“Ca’cché ” – Locuzione univerbata (fusa cioè in un unico termine) del dialetto cilentano, difficilmente inquadrabile in una voce corrispondente in lingua italiana dotata della stessa efficacia e della stessa sintesi. Si usa come forma avverbiale per siglare e sostenere una dichiarazione o un parere altrui. Rientra nella gamma di quei termini che accompagnano la conversazione nel tentativo del
parlante di mantenere un legame comunicativo con il suo interlocutore.
Letteralmente dovrebbe corrispondere a “ché altro!” lasciando sottintendere la prosecuzione di un significato modulabile ed estensibile – con una sfumatura interrogativa ed esclamativa insieme – come “che altro se non ciò che hai detto tu or ora?”.
Vero è che è adoperato in modo inconsapevole, quasi un intercalare, forma di cortesia, un modo per esprimere all’interlocutore: “ti ho ascoltato, concordo, non ci sono altre domande, come potrei contraddirti!”. Quando è usato come forma di cortesia, orpello formale o pura voce d’appendice nella conversazione, sembrerebbe non prestarsi ad analisi granché significative ed essere confuso con un elemento spontaneo assorbito e adottato acriticamente, per convenzione, nel linguaggio .
Eppure, un senso lo ha, ed anche di civiltà in qualche misura. In questi casi si rivela, infatti, come manifestazione di buona educazione o di diplomazia. Nella cultura e nella società cilentana ricorre il gesto tipico di approcciarsi all’altro rivolgendogli una frase, una domanda, o esprimendo semplicemente un pensiero quand’anche fosse solo una considerazione sul maltempo o sul freddo, da un balcone all’altro, alla posta o in fila nella sala d’attesa del medico. È un approccio gratuito, espresso con un puro intento di coltivare un legame, al quale si è socialmente obbligati a rispondere, anche per cortesia, se anche non interessasse l’argomento.
In quel caso il “ca’cché ” è la formula che coniuga ascolto, creanza, attenzione, con l’evitare di elaborare una risposta articolata, complessa e meditata e convergere piuttosto verso una formula liquidatoria e sbrigativa (“si cuntìnua a chiòve accussì sa’ cchè chièna ca vòle scènne!” al che l’interlocutore, nel prenderne atto, risponde “Ah, ca’cchè!”).
Può assumere anche una valenza ironica quando l’interlocutore dice una qualche castroneria talmente inverosimile che l’altro preferisce concordare piuttosto che impelagarsi a contraddirlo ed assumersi la fatica di un’argomentazione critica che già in partenza si è consapevoli che non potrebbe essere colta dall’altro (“Oh, ma ‘u ssà’ ca lu mùnno è chiano, ati ca chìri ca rìceno ca è tùnno!”, al che l’interlocutore sbrigativo non può che rispondere “Ah, ca’ cchè” dove la “ah” iniziale sta a indicare il vocativo che spesso lo precede).
Nei contesti in cui la conversazione assume, invece, contenuti consapevoli, come sui temi dell’esistenza, o nella interpretazione di fenomeni o eventi dinanzi ai quali i conversanti intendono assumere toni di serietà, il “cacchè” rivela una forza di logos più profonda (“Oh, Nicò, pòver’Itàlia, che fìne ch’àmo fàtto cu’ ‘stu cuvèrno”, al che l’interlocutore può allora rispondere con efficacia di sintesi, di adesione, di convinzione, con un sonoro “ca’cchè”, tanto più carico quanto più è preceduto da uno o due secondi di pausa, o fissando lo sguardo nel vuoto, o accompagnando la risposta con una piccola distorsione delle labbra che, nel linguaggio dei gesti, esprime un indicibile disprezzo).
Altri esempi assumibili in questa categoria di contesti verbali di comunicazione possono essere: “Ma tu a’ visto ‘stu feisbùch? tinìa raggiòne Umberto Eco, ca recìa ca ccà ngè parlano ‘na maniàta re stuperùni, ca ‘na vòta ‘nnanti lu bàrro com’aprìano vòcca accussì ‘i stutàvano tànto ca èrano stùpiri!” e la risposta “ca’cchè” può seguire in questi casi con una inflessione intonante ad una rassegnazione; oppure “Me sà, ca ‘u sìnnico, a còme se stàno mettènno le còse, ‘u face Ronn’Antonio ppe’ l’ati riec’anni”, al che l’interlocutore può rispondere un “ca’cchè” accompagnato con una alzata di spalle, con leggerissima inclinazione del capo con tentativo di far unire mandibola e spalla, gesto che, sempre nel linguaggio dei gesti, esprime l’ovvio o un indistinto fatalismo.
Provando a scomporre grammaticalmente la locuzione nei suoi due elementi “ca” e “cchè”, si può ipotizzare che il “ca” corrisponda a quella che in italiano è la congiunzione “chè” adoperata col senso di “perchè” e scritta con l’accento in quanto pronunciata con tono vibrato. Questa congiunzione “ca”, del resto, è già presente nel dialetto in frasi del tipo “Nè, e dàmme ‘na màno, ca me sconòcchio”, dove il “ca” sta per il “perché” causale.
Il secondo elemento “cchè”, invece, potrebbe corrispondere all’italiano “che cosa?” seguito da un segno interrogativo che tronca di netto una possibile domanda che per brevità si tace poichè per convenzione il senso della nostra risposta è stato colto dall’interlocutore senza bisogno di dilungarsi oltre, come a dire, nel complesso: “Perchè, cos’altro?” nel senso “perchè, che altro si potrebbe dire in contrario?”.