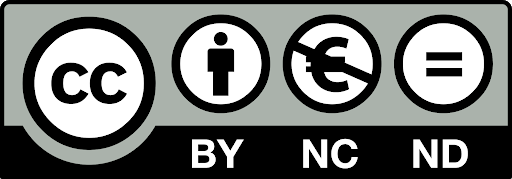Nel dialetto cilentano, “vòito” si può tradurre con “vagabondo”o “girovago”, associato, però, ad una accezione negativa e lievemente spregiativa che delinea, più nei dettagli, una persona senza fissa dimora o caduta in disgrazia per vicende connesse ad una condotta irresponsabile o ad un destino avverso e, qualche volta, ridotta a “balordo”.
Si dice anche per indicare persona che nel suo girovagare si presuma viva di espedienti o che comunque non è inquadrabile in una categoria di mestieri.
Il “vòito” può anche assumere una accezione romantica quando indica una persona che, secondo i parametri dell’opinione pubblica vigente in un determinato microcosmo, non si presti ad assumere stili di vita sobri, slegato da remore, o che volontariamente decida di perseguire una dimensione ebbra di viaggio e per questo lasciare nella memoria altrui un interrogativo di vaghezza, come se nessuno ne potesse riferire una destinazione o un indirizzo tra le infinite vie del pianeta: “se ne partette vòito ppe’ l’america”.
“Vòito”, per questo, è colui abbandonato al suo destino, irrecuperabile, non più in grado di rientrare nei ranghi. In un ideale ed immaginario consesso di saggi ed anziani contadini, abituati a cadenzare il tempo con le scadenze della semina e dei raccolti e con ogni incombenza che fosse utile alla sopravvivenza alimentare per sé e per la famiglia, sarebbe stato annoverato fra gli esempi di “vòito” anche Ulisse il quale, anziché pensare di tornarsene a casa a guerra finita e provvedere ad una moglie e al figlio, pensava bene di andarsene “vòito” per mari e per ninfe.
Col termine “vòito” spesso le madri rimbrottavano i loro figli, colpevoli di allontanarsi di casa senza dare indicazioni del loro percorso o di intrattenersi in giochi futili a perder tempo: “‘A iuto facenno ‘u vòito appriesso a lu pallone mbece re aiutà a pàtrito a purtà le lèuna”.