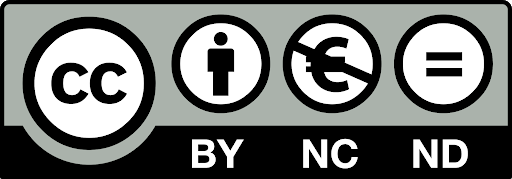“Chera-vànna” – “Vànna” è un sostantivo femminile singolare del dialetto cilentano – presente anche in altre parlate meridionali – che si usa preceduto dagli aggettivi dimostrativi femminili “chèra” e “chèsta” con i quali si fonde in una vera e propria locuzione o unità lessicale: “chèra-vànna”, “chèsta-vànna”.
“Vànna”, anzi “chera-vànna” e “chesta-vànna”, sono un luogo fisico, una parte di territorio diviso da un altro da confine naturale più o meno marcato, quale un fossato, un vallone, un’altura. Ad esempio, per gli abitanti della pianura dell’Alento, “chèra vànna” e “chèsta vànna” indicano, tuttora, semplicemente i luoghi al di là o al di qua del fiume.
La sfumatura di “logos” che si rinviene nel termine sottolinea un luogo che si possa raggiungere mediante un “passaggio”, un “attraversamento”, un “superamento”, un “guado”. “Chera-vànna”, quindi, sottintende un percorso che conduca in un altrove che è sì ben determinato, ma anche un poco poco meno familiare, almeno rispetto alla posizione in cui il parlante assuma di collocarsi in un “centro” non soltanto fisico, ma anche psicologico. “Chèra-vànna” è l’espressione che utilizza chi, per indicare “l’altrove”, l’ “altro luogo”, l’ “altra parte”, implicitamente dichiari di trovarsi in una posizione di cui, invece, senta e percepisca l’appartenenza e il dominio sicuro (“iètti a pàsce a cheravànna”, “nè Zi, vienitènne a chestavànna”).
Un’analisi della parola “vànna” dischiude solchi che si diramano in una raggiera di significati nei quali, tuttavia, è possibile enucleare una radice comune. Il termine è una derivazione da “banda” che comprende più definizioni in più settori. Il più appropriato, e che più si avvicina alla definizione di “vànna”, “chera-vànna” e “chesta-vànna”, come adoperati nel parlato dialettale, si rinviene in geometria dove indica “ciascuna delle due parti (o semipiani) in cui una retta qualsiasi divide il piano” (dal Vocabolario Treccani).
Tale definizione, mutuata evidentemente dal linguaggio comune, ben rappresenta la proiezione anche ideale e psicologica dell’individuo rispetto al territorio. “Bandiera”, ad esempio, con la quale si usa rimarcare e rendere visibile un confine al forestiero o straniero, deriva anch’essa da “banda” e in questo etimo reca una fusione tra “uomo” e “terra”, tra “gruppo di uomini” e la “loro terra”.
Ugualmente la “banda” come “gruppo” di individui legati ad un progetto (che può essere bellicoso o criminoso, ma anche per fini di suonare insieme), contiene un contrassegno di distinzione dei suoi componenti e sulla natura del loro agire e finalità.
L’etimo di “vànna”, come anche di “banda” (che si rinviene pressoché identico anche in altre lingue europee come il provenzale e spagnolo “banda”, il tedesco “band”, il francese “bande”, il gotico “bandi”, col significato di “legame”), deriva da una radice indoeuropea “Badh” e “Bandh” con il significato, appunto, di “legare” (così si riporta nel “Dizionario etimologico della lingua italiana” di Ottorino Pianigiani).
Il “chera-vànna” e “chesta-vànna”, pertanto, esprimono anche un luogo identitario: quand’anche riferito ad uno spazio fisico ristretto, distinguono la limitata propaggine di uno spazio domestico rispetto all’altro luogo che sta oltre un recinto, di là, oltre il fiume, oltre il vallone, oltre il dirupo, tutti ben visibili.
“Chera-vànna” e “chesta-vànna”, al pari degli avverbi tuttora diffusi come “racchènne” e “raddènne”, sono anche un segno antropologico e culturale di un’indole individualistica del Cilentano nel rapportarsi con lo spazio, nota dalla quale sono derivati “campanili” e velleità identitarie non adeguatamente sostenibili dinanzi a ben più imperiose contaminazioni e crogiuoli di razze derivate dal groviglio di esodi e di occupazioni di cui il Cilento è stato scenario.